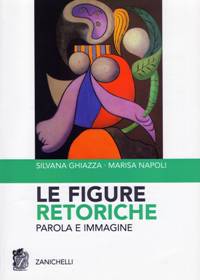Per esempio, l’ora pro nobis, formula rituale, è un’epifora, cioè la ripetizione di una parola (o gruppo di parole) alla fine di più frasi consecutive. Come “«e Bruto è uomo d’onore... »” che Antonio, nel Giulio Cesare shakespeariano, ripete a conclusione di ogni periodo del monologo. Per l’epifora valgono le possibilità di variazione dell’anafora (ripetizione della stessa parola o sintagma all’inizio di frasi successive). E non si confonda l’epanortosi con l’epanalessi! In ballo abbiamo qualcosa come novantadue figure retoriche. Se contiamo le “sottofigure”, siamo a oltre trecentocinquanta. Le troviamo trattate o citate o esemplificate nel libro in titolo con un piglio e una chiarezza espositiva davvero encomiabili. Le figure retoriche sono ingranaggi dove inciampa il discorso? Si è indotti a pensare che quando ci si concentra sui vari movimenti della gamba mentre si cammina, si rischia di inciampare. Ma in effetti nemmeno i campioni della retorica classica (i sofisti) erano frenati dall’analisi delle quattro operazioni fondamentali che riguardano le figure retoriche (addizione, sottrazione, spostamento, sostituzione), perché puntavano sull’energia della parola e sull’alchimia del linguaggio per avere il sopravvento. Semmai l’analisi “dei meccanismi logici profondi che generano le figure”1, soprattutto se rimodernizzata, determina una efficace didattica e presa di coscienza. Ma in particolare illumina la percezione dei meccanismi mentali che chi parla o scrive o raffigura si prefigge di mettere in moto per condizionare il fruitore. Va da sé che lo studio delle figure retoriche è indispensabile anche nella esegesi di testi antichi. Dunque questo studio, in un’ottica aggiornata, non è sorretto da una puntigliosità tassonomica, bensì dalla passione e dalla consapevolezza che trattasi di un nodo fondamentale del linguaggio sociale. Il punto cruciale è ancora quello enunciato da don Milani: le trecento parole non bastano e basteranno sempre meno al fine di interloquire o di non farsi travolgere da chi ha le leve della comunicazione, e cioè il potere economico, prima ancora che quello politico. “Punto di forza del volume è l’analisi della dimensione iconica che, sulla base della ricerca semiologica applicata alla comunicazione di massa, fornisce strumenti di lettura del linguaggio della pubblicità e di valutazione estetica (dalle arti figurative e plastiche alla fotografia)”2. Insieme alle “note storiche che corredano ogni figura”3, va sottolineata l’assoluta efficacia grafica che rende veramente fruibile il messaggio e la modernità pedagogica del libro.
Beno Fignon
1 Silvana Ghiazza e Marisa Napoli, Le figure retoriche. Parola e immagine, Zanichelli, Bologna, 2007, quarta di copertina.
2 Silvana Ghiazza e Marisa Napoli, op. cit. (vedi nota 1), quarta di copertina.
3 Silvana Ghiazza e Marisa Napoli, op. cit. (vedi nota 1), quarta di copertina.
|